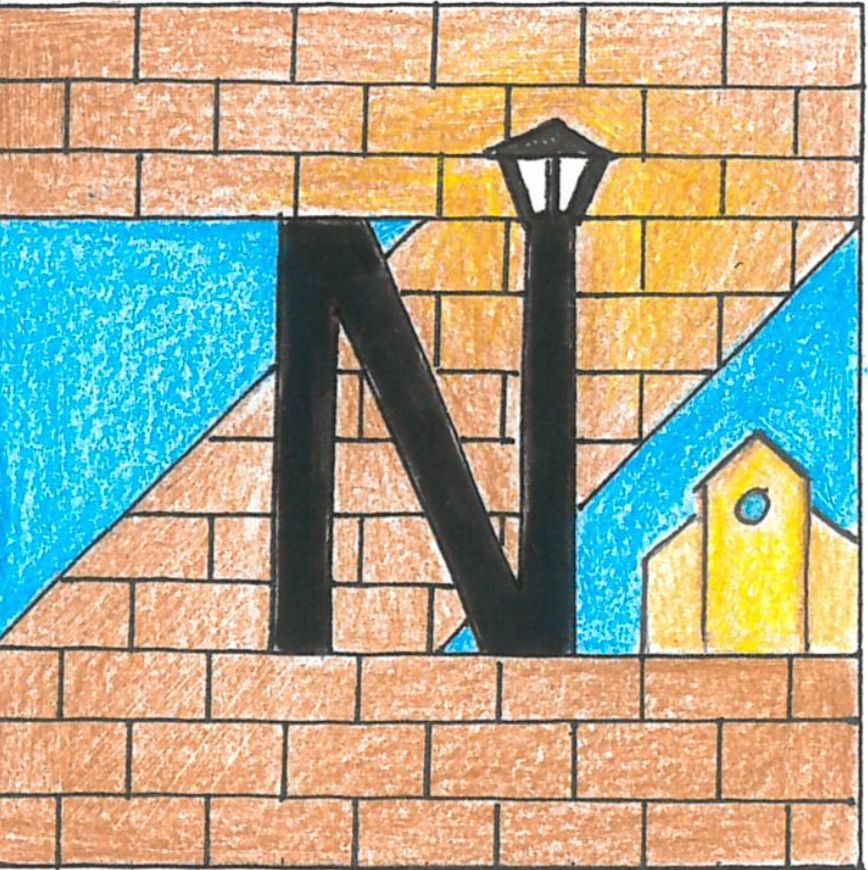Niccolò Piccinni: un legame indissolubile tra la musica e la città di Bari
Niccolò Piccinni (Vito Niccolò Marcello Antonio Giacomo) nacque a Bari il 16 gennaio 1728 da Onofrio (dal 1719 violinista e contrabbassista nella basilica di S. Nicola e nel 1743 maestro di cappella ad interim) e da Silvia Latilla, sorella dell’operista Gaetano. È considerato uno dei maestri dell’opera buffa napoletana.
Ricevuta dal padre una prima formazione musicale, si trasferì a Napoli e lì proseguì gli studi nel conservatorio di S. Onofrio; durante questi anni di studio ebbe comunque modo di tornare a Bari per coadiuvare l’attività paterna. Il debutto operistico avvenne nell’autunno del 1754 al teatro dei Fiorentini di Napoli con Le donne dispettose.…