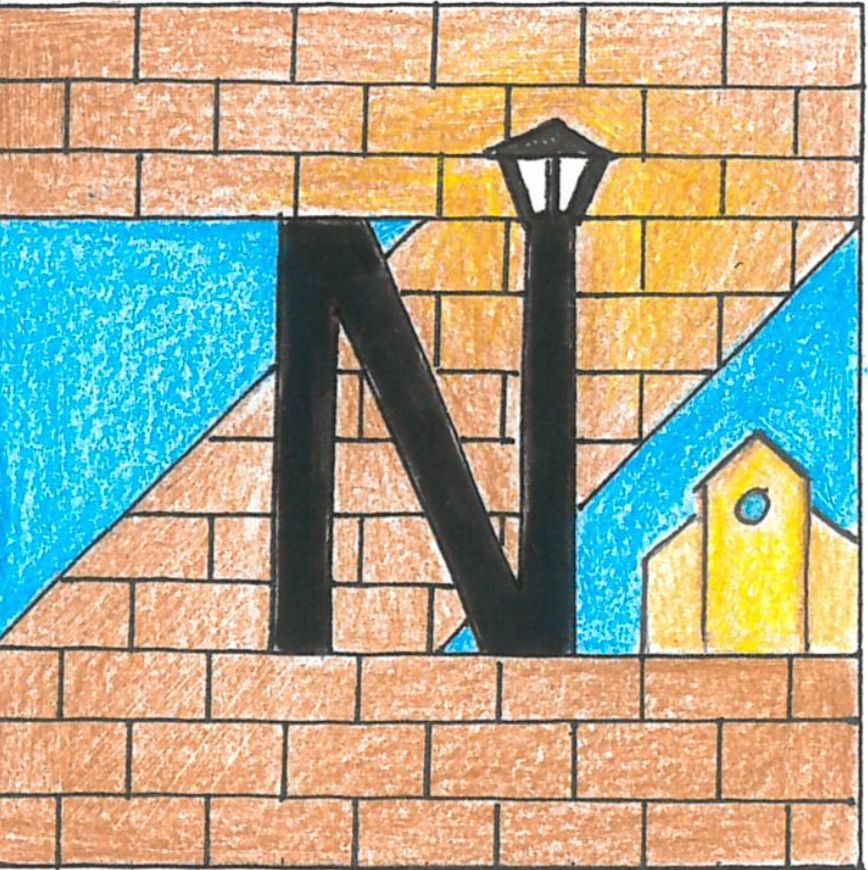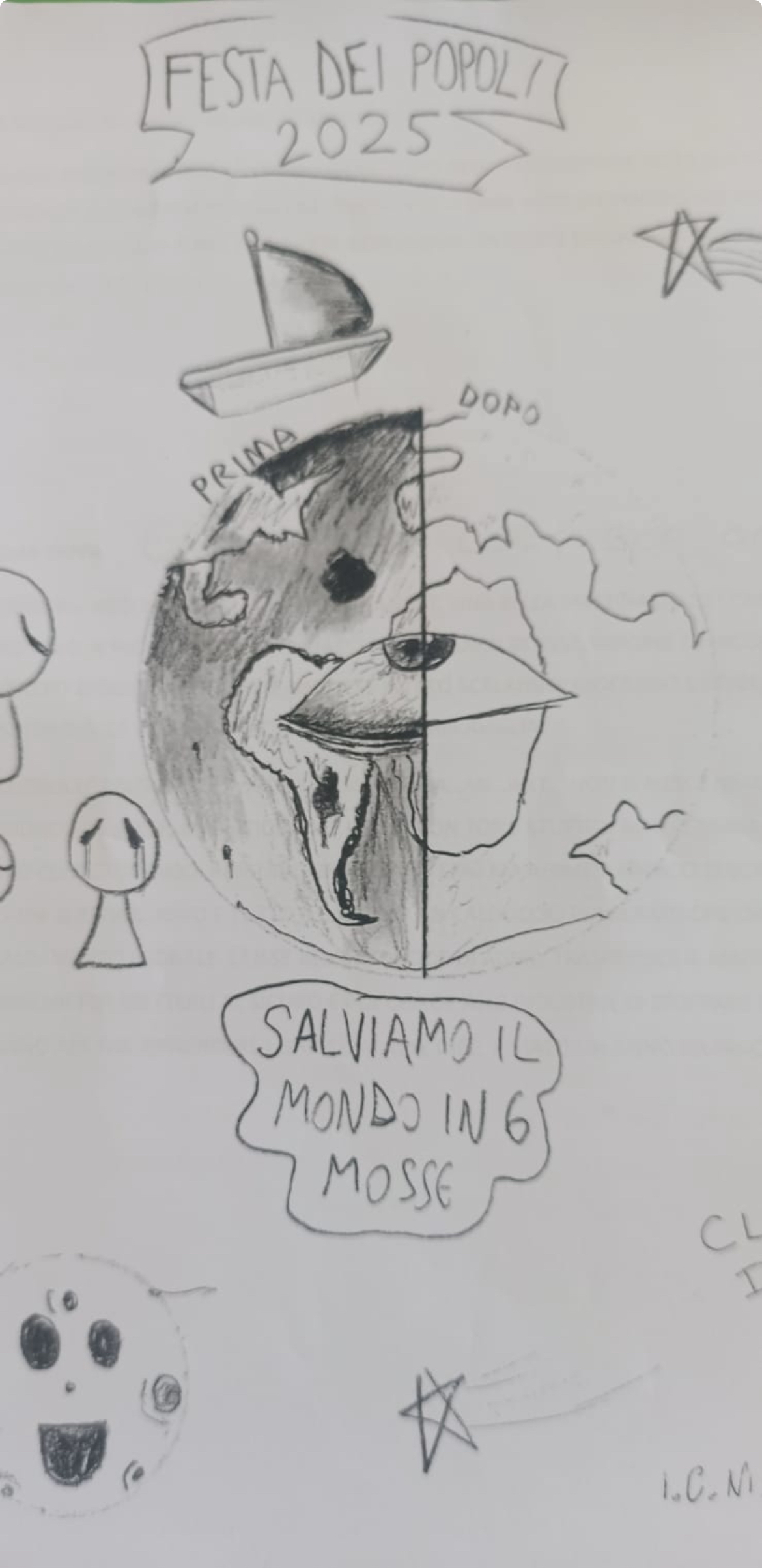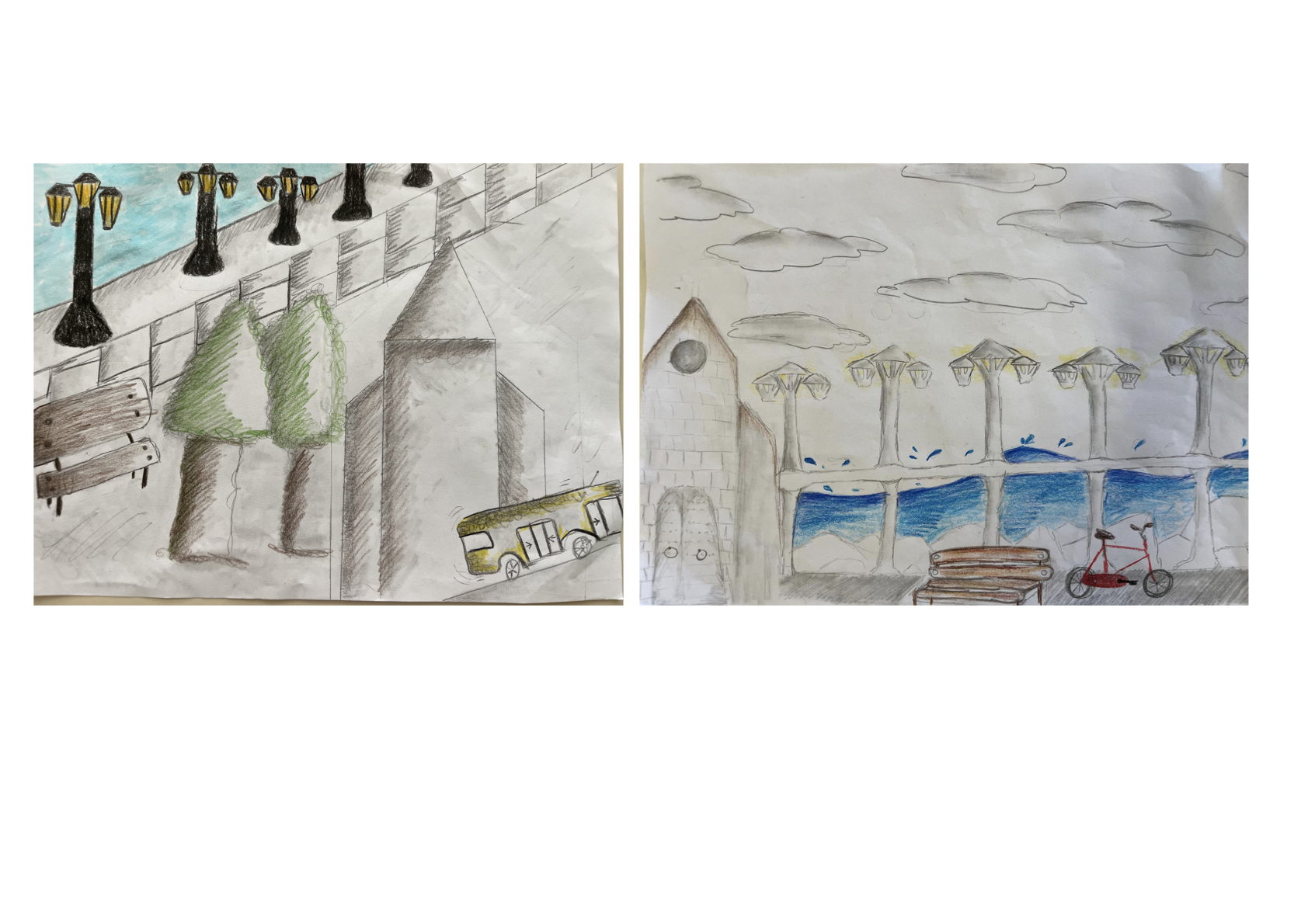Donne
Fin dall’antichità alla donna non è quasi mai stato riconosciuto il suo valore, non le venivano infatti riconosciuti diritti bensì solo doveri. Le donne erano considerate fragili e non potevano prendere decisioni. Erano obbligate a badare ai figli, obbedire al marito, che aveva potere su di lei, e svolgevano solo le faccende domestiche in casa.
Un esempio invece di donne potenti si riscontra nell’antico Egitto con Cleopatra, prima donna faraona. Anche nell’antica Grecia con Gaia, personificazione della Terra che genera le razze divine, si esalta il potere della donna…ma solo perchè era una Dea! Nell’età antica, infatti, ed in particolare in Grecia, le donne erano escluse dalla vita sociale e politica.…